POST-IT
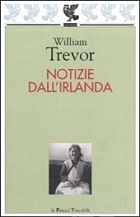
RACCONTI DALL'IRLANDA
Per comprendere il rapporto tra gli irlandesi e la letteratura basta fare due passi a Dublino. Si può iniziare dando un’occhiata alla Old Library del Trinity College ed ammirare l’impressionante biblioteca storica dell’Università, che mostra tutto il suo fascino nella Long Room. Un corridoio di oltre sessanta metri di lunghezza completamente circondato da un immensa libreria di legno ripiena di oltre 200.000 volumi antichi, perfettamente catalogati. Per arrivarci bisognerà passare per le stanze che mostrano la bellissima miniatura scritta e rilegata dai monaci, risalente all’ 800 d.c conosciuta come il “Book of Kells”. Oppure si può andare a Parnel Square, in fondo ad O’Connell Street e visitare il Dublin Writer Museum. Li, all’interno di una splendida palazzina bianca, in sole due stanze, sono racchiuse foto, ricordi, libri originali e brevi biografie di un impressionante numero di scrittori irlandesi, nella maggior parte dei casi, nati e cresciuti a Dublino. Qualche nome? Si va dai “classici” come Jonathan Swift e Bram Stocker a quattro premi Nobel della letteratura, come William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett e Seamus Heaney , nobel rispettivamente nel 1923, 1925, 1969 e 1995. Per finire, si fa per dire, con Oscar Wilde e James Joyce.
E proprio per gli appassionati dell’autore dell’ “’Ulysses”, poco lontano dal Museo degli scrittori, si può visitare il James Joyce Centre al 35 di Great George’s Street, dove si continua a studiare e ricordare vita e opere del grande autore dublinese. Poche cose, ma suggestive ed interessanti, come la ricostruzione della sua povera e modesta stanza-studio all’epoca del suo autoesilio triestino. E poi foto, libri e soprattutto una monografia interattiva sull’Ulisse, con le critiche contraddittorie che accolsero il testo alla sua uscita, l’analisi dei personaggi e degli stili usati nel libro. E se poi non ne avete abbastanza, potete sempre andare a farvi un brunch, sabato o domenica, da Davy Byrnes, al 21 di Duke Street, una perpendicolare dell’affollatissima Grafton Street, in quel pub dalla facciata blu marino, da cui ogni anno parte il 16 giugno (giorno in cui Joyce conobbe la sua compagna Nora Bamacle ) il Bloomsday, il giro per la città della capitale irlandese sulle tracce di strade e luoghi narrati da Joyce, proprio come foste il mitico Signor Bloom.
Per gli amanti della poesia e di Yeats , si può andare alla National Library d’Irlanda, al 2 di Kildare Street. Qui oltre a consultare antichi testi o giornali, c’è una splendida mostra monografica multimediale sul poeta e mistico dublinese, dove i reperti originali si sprecano. Dalle foto di famiglia, ai taccuini che Yeats portava con se durante i suoi viaggi e su cui annotava impressioni e frammenti di poesie che avrebbe poi sviluppato e pubblicato.
Questo senza parlare dei tanti scrittori contemporanei che sono nati in questa terra e che ci hanno già lasciato libri di culto, da “The Commitments” di Roddy Doyle a “La metà di niente” di Catherine Dunne o “Le ceneri di Angela” di Frank McCourt , solo per citarne alcuni.
O delle tante librerie che spuntano in ogni angolo della città, dove dominano i tanti scaffali riservati alla narrativa breve, di cui, come si sa, gli scrittori irlandesi sono maestri. Adoro la narrativa breve. Se poi ne sono protagonisti uomini e donne “comuni” con le loro storie “ordinarie” di tutti i giorni, mi piacciono ancora di più. Quella del racconto è certamente un arte, dove attimi di esistenze, vengono descritte in poche magistrali righe, nel loro momento cruciale, come fosse uno scatto di un fotografo. Spesso dei personaggi che popolano queste storie “minime”, non sappiamo niente o comunque poco. Però si intuisce. Certamente se ne capisce il dramma, che è quello dell’esistenza di ogni giorno. Racconti che non parlano di grandi epopee, e neanche di grandi gesta eroiche.
I misteri che li popolano, non sono quelli dei Templari o dei grandi enigmi della Storia.
Ma sono quelli dell’animo umano, così difficile da capire e da indagare, anche se sono da sempre parte di noi. Vite anonime, che scivolerebbero via in esistenze quotidiane, senza grossi scosse e che invece, ad un certo punto, si ritrovano a fare i conti con il loro destino. A volte è il caso, a volte sono le circostanze, certamente accade. Svincoli quotidiani, che sembrano imprevisti, ma che spesso rappresentano la catarsi di un lungo percorso che scava dentro come l’acqua nella roccia. Goccia a goccia. Attimi, insignificanti, che pure rappresentano pietre miliari di quelle esistenze, come capita a tutti, ad ognuno di noi. Racconti che in poche pagine ci restituiscono il senso di una vita. Sconfitta o vincente, transitoria o definitiva che sia. Come diceva lo scrittore irlandese Frank O’Connor “l’essenza del racconto sta nel cogliere il momento in cui un individuo, di fronte ad una crisi che modifica radicalmente la sua vita, si rende conto che nulla sarà più come prima”.
James Joyce , colui che forse più di ogni altro ha rivoluzionato la letteratura del novecento, nei famosissimi “Racconti di Dublino” (Dubliners, 1914) , scritti praticamente quasi per intero dal suo esilio triestino, esplora vizi e virtù, sogni e passioni della sua gente e della sua città, tirandone fuori una sorta di corollario che va ben al di là dell’ambientazione storica e sociale del tempo. Un libro che è un ritratto universale dell’animo umano, solo per caso ambientato a Dublino, dove vengono toccati un infinità di temi esistenziali, dall’adolescenza all’età adulta, dalla passione alla frustrazione, dalla solitudine all’amicizia, dall’amore alla morte.
Ecco come con in poche righe, il grande Joyce ci descrive l’atmosfera di Dublino nel racconto “ Due Galanti” (in “Gente di Dublino”, James Joyce ed. Giunti Editore): “Andarono avanti lungo Nassau Street e poi voltarono in Kildare. Poco distante dai portici del circolo un arpista suonava in mezzo alla strada, attorniato da un piccolo pubblico. Pizzicava le corde con noncuranza, lanciando rapide occhiate di tanto in tanto al viso di ogni nuovo venuto e di tanto in tanto, pure con aria annoiata, al cielo. Anche la sua arpa, incurante che la sua fodera le fosse caduta intorno alle ginocchia, sembrava annoiata così degli occhi estranei come delle mani del padrone. Le note della melodia risuonavano profonde e piene.
I due giovani proseguirono senza parlare, seguiti da quella musica malinconica. Quando arrivarono allo Stephen’s Green attraversarono la strada. Il rumore dei tram, le luci e la folla, li trassero dal silenzio.”
Il lungo isolamento culturale ed economico che ha attraversato l’Irlanda per lunghi tratti del novecento, si fa ancora più pungente in un paese scarsamente abitato dove, ad eccezione di Dublino, Galway o Cork, la regola sono i piccoli paesini di campagna. Un isolamento, a volte ancor più acuito dalle regole ferree di una tradizione ultracattolica, tipica della Repubblica d’Irlanda.
Ecco come William Trevor , alla fine dello splendido racconto “La Sala da Ballo”, che apre la sua raccolta “Notizie dall’Irlanda” (Guanda, 1998), ci descrive la visione di Bride, una giovane ragazza della campagna irlandese, divisa tra il dovere di accudire il padre malato e la voglia di andarsene, ma che decide di consegnarsi ad un futuro che sa molto di rassegnazione: “Inforcò la bicicletta e discese dal pendio; Bride invece spinse la sua fino in cima alla salita, poi montò anche lei. Pedalò nella notte come aveva fatto ogni sabato per tanti anni e come non avrebbe fatto mai più perché ormai aveva raggiunto una certa età. Avrebbe aspettato, adesso, e prima o poi Bowser Egan sarebbe andato da lei, dopo che fosse morta sua madre. Suo padre nel frattempo sarebbe morto anche lui. Avrebbe sposato Bowser Egan perché le sarebbe venuta la malinconia, a star sola nella fattoria.”
Alla fine degli anni ottanta, prima della risalita economica, i giovani d’Irlanda cercano di resistere, combattuti tra la voglia di andarsene o quella di restare in una terra che contemporaneamente amano e odiano, teneri e fragili, persi tra la ricerca di una occupazione e le bevute di birra, magari al suono di una canzone rock. Così ce li descrive Joseph O’Connor al contempo duro e compassionevole, nei suoi racconti del suo celeberrimo libro d’esordio “I veri Credenti” (True Believers, 1991, Guanda) , da cui il seguente passo, tratto dal primo racconto della raccolta, “L’ultimo dei mohicani”: “Eddie si ritirò pochi mesi prima dagli esami finali. Lasciò un messaggio sul mio armadietto dicendo di averne abbastanza. Andava a Londra per entrare nel mondo del cinema. All’inizio avrebbe scritto, ma poi sperava di poter dirigere qualche film. Londra era il centro di tutto. D’altra parte era disgustato e stanco di questo posto. Era il nulla. Un sopravvalutato paradiso fiscale per popstar e turisti coi soldi. Una palude culturale dimenticata dal tempo. Diceva che nessuno aveva mai combinato qualcosa restando in Irlanda. Bisognava andarsene per essere presi in considerazione”.
Paolo Mattana © 2007