POST-IT
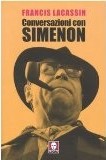 IL BISOGNO DI RACCONTARE
IL BISOGNO DI RACCONTARE
Così esordisce la scrittrice canadese Mavis Gallant, nella prefazione alla sua bellissima raccolta “Al di là del ponte e altri racconti” (BUR, 2005). “Samuel Beckett, rispondendo alla banale domanda di un giornale parigino – “perché scrive?” – , disse che era perché non sapeva fare altro: “Bon qu’a ça”. Georges Bernanos diceva che scrivere era come remare su una barca diretta al largo: la costa scompare, è troppo tardi per tornare indietro, e il vogatore diventa come lo schiavo di una galea. Quando Colette aveva settantacinque anni ed era paralizzata dall’artrite disse che finalmente poteva scrivere tutto ciò che voleva senza dover far conto su quanto le avrebbe fruttato. Margherite Yourcenar dichiarò che, se avesse potuto ereditare la proprietà lasciatele da sua madre e persa al gioco da suo padre, forse non avrebbe mai più scritto una riga. Jean-Paul Sartre disse che la scrittura è fine a se stessa..” Poi più avanti la Gallant prosegue: “Non so ancora cosa spinga un individuo sano di mente ad abbandonare la terraferma e passare tutta una vita a descrivere persone che non esistono. Se davvero si tratta di un gioco fanciullesco, un estensione del “facciamo finta che” tipico dei bambini – cosa che viene spesso confermata da chi scrive di scrittura – allora che dire del desiderio urgente che spinge a farlo, a fare quello e nient’altro? E come si può considerarla un occupazione più razionale dell’attraversare le Alpi su una bicicletta da corsa? Forse l’addetto culturale di un’ambasciata canadese che mi disse “Sì, ma lei cosa fa veramente?” stava esprimendo un parere, da adulto. Forse uno scrittore è, in realtà, un bambino sotto mentite spoglie, con la capacità propria dei bambini di vedere gli adulti lucidamente, di descrivere con precisione un’atmosfera, di improvvisare quando cerca di dare un senso al comportamento dei grandi.”
Bellissimo. Nulla da aggiungere.
Dal Canada all’Irlanda, un altro mitico scrittore di racconti, William Trevor, l’autore de Il viaggio di Felicia, più volte candidato al Nobel, si racconta ad Enrico Franceschini su La Repubblica del 19 gennaio scorso, in occasione della sua recente vittoria al premio letterario Nonino. “Qual è la differenza essenziale fra il racconto e il romanzo?” “ Il racconto è l’arte di dire molto con poco. L’arte di lasciar fuori, di togliere anziché di aggiungere, del non detto. Scrivere un racconto è molto diverso da scrivere un romanzo: devi lasciare una grossa parte di quello che accade all’immaginazione del lettore. E’ la forma che io preferisco”. “Mi domando, restando in argomento, se ha letto e le piace un altro scrittore dallo stile semplice, Georges Simenon.” “Simenon! Mi fa piacere che lo abbia tirato fuori. Certo che l’ho letto e mi piace molto. Mi piace appunto il modo semplice, chiaro e diretto in cui narra una storia, l’ordinarietà del suo stile. Uno stile che viene dalla tradizione orale di raccontare :scrivere come si parla. Mentre lo stile troppo ornato,, barocco, pretenzioso, mi suona falso, artificiale, lontano dalla realtà”. “Quali sono allora, la parte più brutta e la parte più bella dello scrivere?” “La più brutta è la frustrazione di non riuscire a rendere sulla pagina esattamente quello che hai in testa, il che significa rimettere le mani su ciò che hai scritto, lavorarci di nuovo, aggiungere, togliere, correggere, cambiare, limare. E la parte più bella è in fondo la stessa cosa: rileggersi e riscrivere, finché t’accorgi che finalmente tutto fila come vorresti. Anche se poi, se rileggi a un anno di distanza, ti accorgi che non fila proprio perfettamente. Perciò non rileggo mai i miei libri. Mi basta ricordare i bei momenti passati a scriverli.”’.
Ecco allora come ci racconta il suo leggendario modo di scrivere e sentire la scrittura, l’immenso e forse il più prolifico tra gli scrittori contemporanei, l’ appena citato Georges Simenon , rispondendo a una domanda di Francis Lacassin che gli chiede “Perché scriveva romanzi?”. Da “Conversazioni con Simenon”, di (Lindau, 2004). “Ho sempre avuto voglia di scrivere romanzi, come d’altronde tanta altra gente. C’è, si può dire, quasi un terzo dei giovani che si dicono che un giorno scriveranno per lo meno un romanzo. Ma per me era quasi una ricerca di me stesso. Ovvero, ciò che chiamo la ricerca dell’uomo è la ricerca di me stesso, dato che sono un uomo come gli altri. E’ proprio scrivendo romanzi che avevo l’impressione di avvicinarmi all’uomo. Perché, per creare il personaggio di un romanzo, bisogna entrare completamente nei suoi panni. Parlo del romanzo del subconscio. Perché classifico il romanzo in due categorie: ci sono i romanzi scritti con intelligenza, sensibilità, poesia, ecc..; e ci sono romanzi scritti con il subconscio, letteralmente. Ci si mette nei panni di un personaggio, e non si sa assolutamente dove quel personaggio ti porterà, lo segui giorno per giorno, ed è solo all’ultimo capitolo che sai qual è l’esito della crisi. Ebbene, creando un certo numero di personaggi e mettendoli fin dal primo capitolo in una situazione che crea automaticamente una crisi, i personaggi devono arrivare fino al limite di loro stessi. D’altronde, domandavano a Balzac: “Che cos’è il personaggio di un romanzo? E Balzac rispondeva: “E’ chiunque là fuori, ma che arriva fino al limite di se stesso” Tutti quanti noi non andiamo fino al limite di noi stessi, o perché abbiamo paura di finire in prigione, o perché temiamo di urtare i nostri simili, o per ipersensibilità, o per buona educazione, come si dice.. Insomma, per un mucchio di ragioni, ci sono poche persone che arrivano fino al limite di se stesse. E almeno fortunatamente, oggi non c’è più quell’educazione restrittiva che si subiva un tempo. Allora, scrivere un romanzo è mettersi le dico, nei panni di un personaggio, è creare un gruppo sociale qualsiasi, cinque, sei, sette persone, poco importa: dunque ci sarà un personaggio centrale, e bisogna solo entrare il più possibile in questo personaggio centrale”. “E’ quasi, anche se il termine è pretenzioso, un operazione psicanalitica quella che lei attua?” “All’incirca, non è così? Per me era cercare di sapere se quel tipo d’uomo avrebbe reagito in quello o in quell’altro modo. E. mi creda, non c’era bisogno di fare sforzi! Alla vigilia dell’ultimo capitolo, non sapevo come si sarebbe sciolto l’intreccio del romanzo, non sapevo assolutamente ciò che sarebbe necessariamente accaduto al mio personaggio. Questi seguiva una sua logica che non era affatto la mia logica. Io vivevo la sua crisi”.
Luis Sepulveda , parla invece della sua visione di scrittore “coinvolto” e lo fa in una lungo interessante libro intervista concessa a Bruno Arpaia. Ecco lo scrittore cileno, in un brano tratto da “Raccontare, resistere” (Guanda 2002) : “Non credo nello scrittore o nell’intellettuale “organico”, perché questa organicità ti costringerebbe a sacrificare troppe cose. Credo invece in una specie di impegno, diciamo, più essenziale, in un impegno nei confronti della parola stessa. Le parole di chi scrive possono avere un’eco vasta e questo comporta una responsabilità etica. La prima esigenza che si pone è quella di accostare la vita nel quotidiano, nel dettaglio apparentemente più umile e marginale. Lo scrittore appartiene al mondo, vive la vita di ogni giorno, beve caffè, compra sigarette… Perciò tutti i tentativi letterari iniziano con lo sforzo di capire il mondo, di spiegarlo prima di tutto a se stessi. Se noi scrittori fossimo incapaci di preoccuparci della quotidianità, delle cose più banali e immediate, saremmo incapaci di interrogarci su tutto il resto. Questa preoccupazione per il mondo ti spinge in qualche modo a prendere partito, a schierarti, e questo schierarsi non lo chiamerei nemmeno «impegno »: in fondo, detesto questa parola perché è comoda, ha qualcosa che fa pensare a un vestito che indossi e togli a piacimento, come quando si è giovani e ci si impegna con una ragazzina, salvo poi impegnarsi con un’altra più carina che si è appena conosciuta. Preferisco parlare di «coinvolgimento». Lo scrittore, secondo me, deve essere coinvolto, deve stare dentro le cose, dentro la vita. Per questo non parlo mai in nome della letteratura o degli scrittori in generale, per questo parlo sempre e solo a mio nome. La responsabilità dello scrittore è personale come quella penale.”
Ancora in Cile, e a parlare questa volta è la regina delle scrittrici sudamericane, Isabel Allende , dal suo sito www.isabelallende.it: “Sul mio lavoro di scrittrice”, scrive: “Spesso la gente mi chiede quanta verità ci sia nei miei libri e quanto io abbia inventato. Posso giurare che ogni parola è vera. Se non è accaduto, accadrà certamente. Non riesco più a tracciare un confine tra la realtà e la fantasia. Prima mi chiamavano bugiarda, ora che mi mantengo con queste bugie mi chiamano scrittrice. Forse dovremmo semplicemente attenerci alla verità poetica". Nel suo Libro degli Abbracci, Eduardo Galeano ha raccontato una storia fantastica, che per me è una splendida metafora della scrittura. “C’era un uomo anziano e solitario che passava la maggior parte del tempo a letto. Giravano voci che avesse un tesoro nascosto in casa. Un giorno i ladri fecero irruzione, cercarono ovunque e in cantina trovarono un forziere. Se lo portarono via e quando lo aprirono scoprirono che era pieno di lettere. Erano le lettere d’amore che l’uomo aveva ricevuto nel corso della sua lunga vita. I ladri stavano per bruciarle, ma ne discussero e alla fine decisero di restituirgliele. Una a una. Una a settimana. Da allora, ogni lunedì a mezzogiorno il vecchio avrebbe atteso l’arrivo del postino. Non appena lo vedeva, gli correva incontro e il postino, che sapeva tutto, teneva la lettera in mano. E perfino san Pietro riusciva a sentire il battito di quel cuore, impazzito di gioia nel ricevere un messaggio da una donna”. Non è forse questa l’essenza giocosa della letteratura?... Un evento trasformato dalla verità poetica. Gli scrittori sono come quei ladri di buon cuore, prendono qualcosa di reale, come le lettere, e con un trucco di magia lo trasformano in qualcosa di completamente nuovo. Quella è la parte migliore della scrittura: trovare i tesori nascosti, ridare splendore agli eventi consunti, tonificare con l’immaginazione l’anima stanca, creare una specie di verità partendo da molte bugie. La buona narrativa non è solo l’eccitazione data dalla trama, ma dà il meglio quando è un invito a esplorare oltre l’apparenza, mette a repentaglio la sicurezza del lettore, mette in discussione la realtà. Sì, può turbare. Ma alla fine magari c’è una ricompensa. Con un po’ di fortuna l’autore e il lettore, mano nella mano, possono imbattersi in particelle di verità. Lo scrittore prova semplicemente un bisogno incontrollabile di raccontare la storia. Non c’è nulla di più, credetemi.”
Paolo Mattana, © 2008