POST-IT
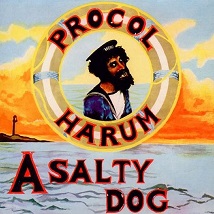 A SALTY DOG, Procol Harum (1969)
A SALTY DOG, Procol Harum (1969)
Non lo so. Sarà per quel suono di gabbiani all’inizio e alla fine del pezzo o per quella voce così evocativa e letteraria di Gary Brooker che canta declamando versi come fosse Samuel Coleridge, o sarà forse per quella storia di vecchi lupi di mare che riflettono sul senso della vita ricordando avventure di navi e di mari lontani, di naufragi, di traversate eroiche tra burrasche e intemperie, o forse sarà più semplicemente perché a me il rock progressivo britannico mi ha sempre sedotto e ipnotizzato come il canto di una sirena. Non lo so. Fatto sta che A salty dog , nonostante abbia oramai compiuto cinquant’anni, mi fa impazzire ancora adesso, ancora più di A whiter shade of pale, che rimane certamente il capolavoro indiscusso dei Procol Harum.
Ma forse la verità è che io con quel brano ci sono cresciuto.
A metà degli anni Settanta infatti ero un bambino che frequentava le scuole elementari e alle cinque del pomeriggio mi piazzavo in cucina davanti ad un enorme televisore in bianco e nero in trepidante attesa di Avventura. Si trattava ovviamente, come tutti quelli della mia generazione sanno bene, del programma della RAI che andò in onda per un decennio a partire dalla metà degli anni ’60 all’interno della TV dei ragazzi. Un programma di documentari che spalancavano finestre su un mondo sconosciuto e che ha fatto viaggiare con la fantasia migliaia di ragazzi portandoli in luoghi mai visti. Montagne impervie, savane sconfinate, abissi marini, animali selvaggi, terre inesplorate. E io mi immedesimavo in quelle storie e sognavo di diventare da grande un esploratore, un antropologo, un naturalista e chissà cos’altro.
Il programma aveva due sigle musicali iconiche. Quella di apertura era She came in through the bathroom window dei Beatles, nella celeberrima versione di un Joe Cocker ispiratissimo che urlava dal microfono scuotendoti dentro come un tamburo mentre sullo schermo scorrevano le immagini dei documentari intervallate da quelle di un cameramen che volteggiava su se stesso con la cinepresa tra le mani. La sigla di chiusura del programma era invece, appunto, A salty dog , dove il canto epico e la malinconica melodia dei Procol Harum, si spandevano per la casa nutrendo la mia immaginazione mentre il teleschermo trasmetteva scene di un'imbarcazione che fluttuava tra onde enormi e venti di burrasca affrontando il mare in tempesta.
Così appena iniziavano le note di A salty dog quella musica mi trascinava all’istante dentro il suo mondo fatto di poesia, avventura e oceani da conquistare. Era come essere in un romanzo di Conrad a navigare per chi sa quali mari a bordo di chissà quale veliero, magari durante un ammutinamento. Oppure essere come il capitano Achab e il suo sottufficiale Starbuck a bordo del Pequod persi con l’equipaggio tra le onde alla ricerca della Balena Bianca.
“All hands on deck, we've run afloat!" I heard the captain cry
Across the straits, around the Horn: how far can sailors fly?
A twisted path, our tortured course, and no one left alive
We sailed for parts unknown to man, where ships come home to die”
"Tutti in coperta, stiamo andando alla deriva!" Ho sentito il capitano gridare.
Attraverso gli stretti, oltre Capo Horn: quanto lontano possono volare i marinai?
Un percorso contorto, la nostra rotta tortuosa, senza che alla fine qualcuno sia sopravvissuto.
Abbiamo navigato in luoghi sconosciuti all'uomo dove le navi vanno a morire”.
La musica andava avanti, e alle pizzicate degli archi si sovrapponevano i colpi della batteria fin quando la musica rock si confonde con quella d’orchestra diventando pura narrazione. E quando il pezzo finiva, c’era ancora il suono dei gabbiani e del mare in sottofondo che ti cullava per qualche istante, come volesse accompagnarti dolcemente verso la realtà, senza dolore, senza farti svegliare bruscamente dal sogno.
“A salty dog, this seaman's log: your witness my own hand”
“Un lupo di mare, questo diario di bordo: il tuo testimone, la mia stessa mano”
Son passati più di quarant’anni da quando ascoltavo A salty dog davanti ad uno schermo in bianco e nero. Quel mondo non esiste più. Un universo che albergava fuori e dentro quel bambino ingenuo di otto anni fatto di fame di conoscenza, voglia di avventura e speranze ancora intatte. Quel mondo non esiste più. O forse è solo nascosto dentro qualche angolo sperduto della mia memoria, conservato dentro qualche cassetto abbandonato assieme alle letture giovanili di Hemingway e Salgari, alimentato da una fiammella che arde ancora vitale, nonostante tutto, e che aspetta solo di essere riportato a galla.
Paolo Mattana © 2019